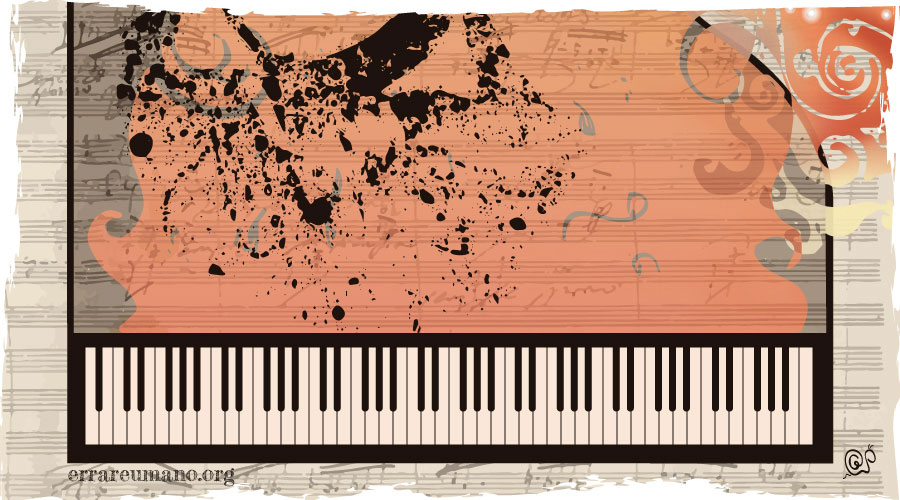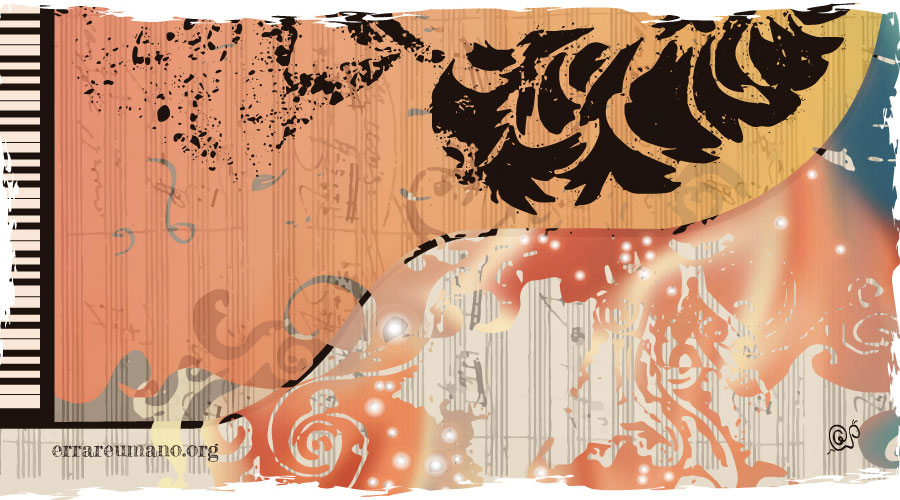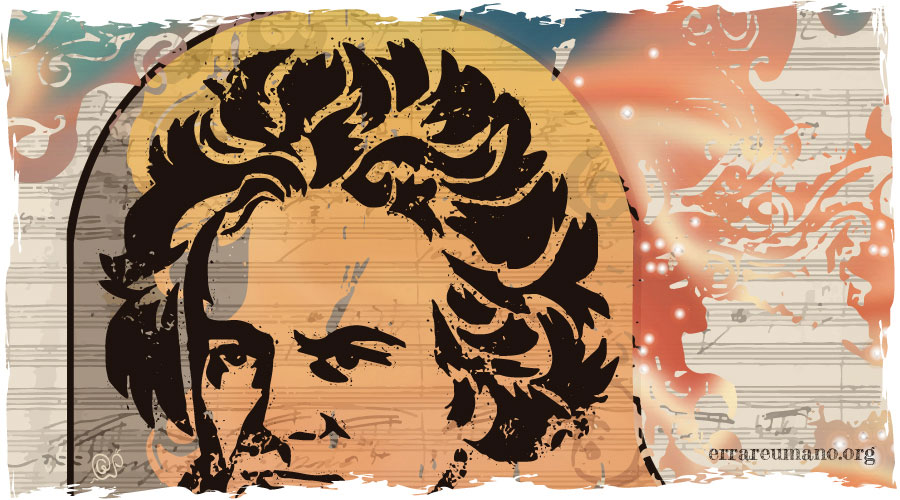Quest’anno si celebra il 250° anniversario dalla nascita di Ludwig van Beethoven.
Noi di ErrareUmano vogliamo celebrarlo a modo nostro,
come meglio sappiamo fare, ovvero attraverso la scrittura.
Festeggiamo insieme questo compleanno tramite una delle sue opere più importanti,
che ha lasciato un segno indelebile nella nostra cultura:
la Sinfonia n. 9 in Re min.
#8.4 Note a margine
I temi, la filosofia, la musica
La produzione musicale di Beethoven può essere idealmente divisa in tre periodi, e l’ultimo, quello alla quale la Nona può essere ricondotto, viene generalmente associato alla stesura di partiture più complesse del musicista tedesco, sia da un punto di vista strettamente musicale che da un punto di vista prettamente filosofico.
La condivisione di temi ed idee tra Schiller e Beethoven è molto stretta. Infatti entrambi condividevano l’amore per i principi filosofici dell’illuminismo tedesco e la lotta alla tirannia ed al dispotismo, a favore di una forma di governo vicina ad un’aristocrazia illuminata che potesse ristabilire l’armonia degli uomini con la natura.
La musica di Beethoven rappresenta quindi un’Europa in rivolta: i filosofi Voltaire e Kant attaccano e criticano duramente gli aristocratici che governano l’Europa da sempre; il piccolo Beethoven ha modo di ascoltare e discutere queste idee nei caffè dell’epoca, dove si può parlare e pensare ad alta voce.

Lo studioso e letterato Heinrich von Stein ha affermato che “le ultime sinfonie di Beethoven raffigurano lo stato idilliaco che Schiller aveva indicato quale meta del poeta moderno.” Questo stato idilliaco è descritto dallo stesso Schiller nel saggio “Della poesia ingenua e sentimentale”: all’inizio l’umanità si trovava in un’Età dell’Oro, dove viveva come insieme armonioso, ma questo stato idilliaco di pura natura è stato annientato dalla venuta della civiltà, trasformando l’umanità in innumerevoli singole unità morali.
In questo contesto, l’artista deve, tramite il mezzo dell’immaginazione, cercare di saldare quella frattura tra genere umano e Natura, ovvero di condurre “noi che non possiamo più tornare all’Arcadia, avanti verso l’Elisio”, inteso come luogo dove godere della “protezione di una divinità benevola ed il nutrimento di una dea della gioia eternamente giovane”.

dipinto di Thomas Cole (1834).
L’Ode alla Gioia allude allora al raggiungimento dell’Elisio, della resurrezione, è il finale di un percorso che si costruisce pian piano durante tutta la sinfonia, che non termina con l’esecuzione corale, ma prosegue in una serie di rapide trasformazioni, quasi a voler auspicare il ritorno dell’idillio originale, che tuttavia non può tornare com’era prima, ma deve necessariamente trasformarsi in qualcosa di diverso.
Al di là di questo, però, l’Elisio può simboleggiare anche il Paradiso inteso come luogo di redenzione cristiana, come luogo di luce raggiunto dopo un cammino di buio.
Il concetto di Paradiso e di Campi Elisi contengono al loro interno, in maniera implicita, il concetto di morte: è all’interno di questi luoghi che si realizza una rinnovata fratellanza.
La morte, però, può simboleggiare non solo la fine della vita terrena, ma può essere anche metafora di un periodo di dolori e sofferenze; allora ci si potrebbe chiedere:
È solo dopo la morte che si può diventare fratelli? E’ solo dopo numerose sofferenze che si può provare un sentimento di vera empatia e solidarietà verso il prossimo? Può essere davvero il dolore la condizione sine qua non la fratellanza e la solidarietà possano essere realizzate?
La vita dello stesso Beethoven è stata piena di sofferenze, ma nonostante ciò, egli non rinuncia alla speranza di realizzare una sincera solidarietà tra gli uomini, tra i popoli.
Il richiamo ad una visione religiosamente cristiana è inevitabile, dato che questa sinfonia è stata scritta contemporaneamente alla Missa Solemnis, ovvero in quel periodo della vita in cui Beethoven si avvicina nuovamente alla religione.
Ecco quindi che i concetti di sofferenza, dolore, morte e resurrezione ispirati dalla Nona acquistano maggior vigore.
La Natura, il caos, la vita
L’elemento Natura è presente sin dal principio della sinfonia, dove il primo movimento può essere visto come il momento della creazione dal caos, e man mano che l’esecuzione avanza, il caos scompare, o per meglio dire, si trasforma. Più che di caos, si può parlare di creazione come emersione di elementi già presenti ma nascosti, richiamando il concetto di creazione di michelangiolesca memoria inteso come eliminazione del superfluo, per fare emergere dal marmo quel qualcosa che esso già contiene. Per dirla con le parole del poeta Shelley, vissuto negli stessi anni di Beethoven:
“La poesia alza il velo che copre la nascosta bellezza del mondo e fa si che oggetti familiari appaiano come se fossero insoliti”.
L’uso della metafora del vulcano usata per descrivere la Rivoluzione esprime a pieno l’atmosfera dell’epoca: il magma intrappolato sotto la crosta terrestre richiama l’energia dell’intera società soppressa dall’ancien régime, che scoppia sotto la pressione del magma sfociando nell’esplosione vulcanica, ovvero nella Rivoluzione.
Il richiamo alla Natura espresso nella Nona deve essere analizzato anche alla luce di ciò: riabbracciare insieme la Natura significa ravvivare e riportare alla luce quei principi che avevano animato l’inizio della Rivoluzione Francese, e di cui Napoleone era, almeno all’inizio, un degno rappresentante: rifiuto dell’aristocrazia e dei suoi privilegi e fondazione di una società laica, dove la meritocrazia fosse il suo motore.
Inoltre, su una rivista musicale dell’epoca (in lingua tedesca), la produzione di Beethoven veniva recensita in questo modo: “le sue grandiose composizioni strumentali… sono in un certo modo come vulcani che riversano i loro fiumi di fuoco in tutte le direzioni”.
La musica di Beethoven quindi servì a portare nel Regno austro-ungarico una descrizione di quelli che erano stati i moti rivoluzionari in Francia. Tuttavia, l’impeto e la forza della musica di Beethoven non furono sufficienti a propagare in Austria lo spirito rivoluzionario francese; infatti, lo stesso Beethoven nel 1794 affermò:
“Credo che fino a quando un austriaco può avere la sua birra e le sue salsicce, è improbabile che si ribelli”.
A Vienna la musica fu usata non per svegliare le coscienze, ma come strumento di controllo e repressione, nella normale routine di teatri e opera. Ancora Hegel, nel suo “Lezioni sulla storia della filosofia” del 1827 afferma: “In Germania questo principio è scoppiato attraverso il pensiero, lo spirito, le nozioni, in Francia sotto forma di fatti”.

Accanto all’immagine del caos, le primissime note degli archi suggeriscono un presagio, un presentimento su un evento futuro, ed è possibile avere un presentimento solo se esso è preceduto da un’esperienza pregressa: da qui la nascita di un elemento ciclico che si rispecchia anche nella ripresa continua di temi precedentemente esposti. Questa tecnica ciclica richiama delle dicotomie, una su tutte quella vita-morte, ma vuole rappresentare anche la ciclicità della Natura, ovvero le stagioni, il susseguirsi dei giorni, l’incessante movimento dei pianeti.

Il concetto di caos richiama alla nostra mente in maniera inevitabile il caos precedente il Big Bang: allora questa sinfonia può diventare metafora della creazione dell’Universo, poiché parte dal nulla, in sordina, si espande ed esplode nel quarto movimento, proprio con l’Ode alla Gioia.
Il richiamo, allora, alla stessa vita umana è inevitabile: così come la Nona si apre con un lieve tremolio e termina in maniera trionfante, allo stesso modo la vita di ognuno di noi inizia con una semplice divisione di una cellula in due, e queste due in altre due, fino all’infinito, fino a creare un organismo complesso qual è il corpo umano.
Lo stile pastorale proprio del III movimento e di parte del II sono un rimando alla Natura che si ritrova e si perde, o che si concede e poi si nasconde; il parallelismo Natura-Felicità è ben presto fatto, e richiama alla mente lo stesso tipo di rapporto amore-odio che anche Leopardi, contemporaneo di Beethoven, aveva nei confronti della Natura.
Tutta la sinfonia può essere vista come un percorso alla ricerca di una riconciliazione tra il genere umano e la Natura, che può portare a uno stato di pace e serenità simile a quello che regnava nell’antica Arcadia. In quest’ottica, l’ ”Ode alla Gioia” rappresenta il punto di arrivo, l’invito ufficiale al ripristino dei sentimenti di fratellanza. Considerato che l’anno della prima esecuzione cade nel pieno dell’epoca della Restaurazione, la Nona rappresenta un tentativo ben preciso di rievocare i principi dell’Illuminismo, che guidano i sovrani illuminati, il cui operato doveva essere mosso da spirito di fraternità e giustizia sociale.
Beethoven, però, non fa terminare la sinfonia con l’Inno alla Gioia, ma prosegue, nel tentativo di cercare un nuovo modello di vita di tipo collaborativo tra i popoli, un modello di unità reso dal punto di vista musicale dall’introduzione del coro in un’opera sinfonica: strumenti e voce si fondono insieme per la realizzazione di un’opera epica.
Un’importante osservazione che è necessario fare per capire bene il significato di quest’opera è il contrasto che c’è tra inizio e fine, sia a livello di tonalità (si parte da un Re min per finire in un Re magg), sia a livello di colore musicale (forte, piano), che di organico (si parte in sordina e nell’ultimo movimento c’è l’esplosione contemporanea di coro ed orchestra).
Nonostante le tematiche prevalentemente illuministe delle quali la sinfonia in questione è intrisa, la Nona è un’opera che guarda al futuro, forse irraggiungibile, come viene testimoniato dall’ampia gamma sonora, e questo vale sia a livello di colori che di timbri (uso di diversi tipi di strumenti), nuovi elementi (presenza del coro) e ricerca delle possibilità espressive della forma sinfonica. Tutto ciò con un solo scopo: descrivere il caos senza sfuggirlo, affrontandolo con uno spirito tipico dell’eroe romantico.
Quindi si può dire che la Nona Sinfonia rappresenta la sintesi e sia il ponte tra il passato (prossimo) dell’Illuminismo ed il futuro (anch’esso prossimo) del Romanticismo, in quanto è un’opera illuminista per i contenuti, ma fortemente romantica per la forma.
L’ascolto, l’eredità
La Nona sinfonia di Beethoven è uno dei pezzi più conosciuti e suonati al giorno d’oggi, ed ha fatto da colonna sonora ad importanti momenti della nostra Storia recente.
Innanzitutto, è l’inno Ufficiale dell’Unione Europea dal 1985, sebbene fosse stata già adottata per il medesimo scopo dal Consiglio d’Europa nel 1972.
Nel 1951 fu usata come apertura del Festival Musicale di Bayreuth, dopo che lo stesso era stato interrotto dagli alleati per via della seconda guerra mondiale.
Nel 1989 ha fatto da colonna sonora alla caduta del muro di Berlino, e fu diretta da Leonard Bernstein il giorno di Natale al Konzerthaus di Berlino ed eseguita dai più grandi orchestrali dell’epoca; per l’occasione, la parola gioia (freude) fu cambiata con libertà (freiheit).
La Sinfonia n. 9 di Beethoven è stata fonte di ispirazione anche per un’importante opera di Gustav Klimt, databile al 1902, il cui nome “Fregio di Beethoven”: è distribuita su 7 pannelli diversi per una grandezza totale di 200×24.4 cm disposti nella parte superiore delle pareti, ed è per questo motivo che lo stato austriaco ha dichiarato l’opera inamovibile; per i prestiti, è disponibile una copia a grandezza naturale.
Tutta l’opera può essere divisa in tre parti:
- L’anelito alla felicità (collocazione laterale, sinistra)
Il cavaliere con l’armatura dorata ascolta le richieste e le preghiere delle figure sulla sinistra: è necessario lottare per la felicità assoluta. Alle spalle dello stesso cavaliere, ci cono due figure allegoriche, la compassione e l’ambizione.

dipinto di Gustav Klimt (1902).
- L’Ostilità delle forze avverse (parete centrale)
Il gigante Tifeo, simbolo delle forze avverse, è raffigurato con sembianze scimmiesche. Alla sua destra ci sono le Gorgoni, figlie dell’angoscia (sulla destra del pannello), mentre alla sua sinistra ci sono le figure della lussuria, dell’impudicizia e dell’incontinenza.

dipinto di Gustav Klimt (1902).
- Anelito della felicità che si placa nella poesia (collocazione laterale, destra)
I sentimenti di gioia, felicità ed amore vengono cantati dal coro degli angeli del paradiso, mentre il cavaliere disarmato abbraccia la sua donna, che simboleggia la poesia.

dipinto di Gustav Klimt (1902).
L’intera opera è quindi la rappresentazione visiva della lotta dell’uomo alla ricerca della felicità pura, eterea, che deve fare un lungo percorso per raggiungere la propria serenità.
Per i suoi ideali di fratellanza e di unione pacifica tra gli uomini, può essere considerata come colonna sonora ideale di ogni movimento di protesta, specialmente quelli contro governi dittatoriali, perché incarna l’aspirazione dell’animo umano ad essere liberi.
Ha fatto inoltre da sottofondo musicale a molti momenti sportivi calcistici, come la Coppa Libertadores o gli europei ed i mondiali di calcio.
E’ stata citata in più film, come ”L’ Attimo Fuggente” ed “Arancia Meccanica“.
Innumerevoli sono poi i film centrati sulla figura di quello che forse può essere considerato come padre della musica moderna.
Lungo questo percorso alla scoperta della Nona vi ho consigliato un’esecuzione diretta da Otto Klemperer con i Wiener Philharmoniker perché vi ho ritrovato una percezione di tempo musicale dilatato rispetto ad altre esecuzioni, che esprime alla perfezione il percorso di maturazione che va dal primo all’ultimo movimento, eliminando una sensazione simile ad un’ansia della ricerca dell’Elisio, inteso come luogo da raggiungere a tutti i costi.
Per avvicinare anche i più piccini alla Nona, ecco una simpatica versione dell’ “Ode alla Gioia” con la firma dei Muppets.
Finale
La Nona è l’ultimo messaggio di un uomo solo, stanco, isolato, ma non per questo sfiduciato, poiché ha ancora la forza di credere in un’umanità pacifica, gioiosa e soprattutto fraterna.
Negli ultimi anni della sua vita Beethoven scrisse in una lettera ad un amico:
“Sono spesso disperato e vorrei morire, perché non vedo alcuna possibilità che tutti i malanni abbiano fine. Dio abbi pietà di me: mi considero praticamente perduto… Grazie a Dio, avrò presto finito di recitare la mia parte”.
E’ davvero straordinario come un uomo come Beethoven, che ha vissuto i peggiori dolori e la suprema maledizione, sciagura, umiliazione per un musicista, ovvero la perdita dell’udito, abbia potuto produrre un pezzo di musica così complesso ed allo stesso tempo così pieno di speranza e serenità.
Recentemente, mi sono trovata a parlare di Ludwig con un amico:
“Io mi chiedo come abbia fatto Beethoven a scrivere la Nona se era sordo”, mi chiese con stupore e meraviglia.
Ed io, con un sorriso pieno di ammirazione, e forse anche con un pizzico d’invidia, gli risposi:
“Immaginazione, molta immaginazione”.
Beethoven è la conferma che l’Arte, quella con la A maiuscola è sofferenza, è esperienza, è vita, e ci dimostra, ancora una volta, il potere salvifico, letteralmente e non, dell’Arte.
Cosa sarebbe stato Beethoven senza la Musica?
Come direbbero i Beach Boys: “God only knows what I’d be without you!”.
Ed io direi, parafrasandoli:
“Solo il Signore sa cosa saremmo stati senza Beethoven”.
Autrice: Annarita N.
Cover designer: Pigutin
Hai perso le puntate precedenti? Puoi trovarle qui sotto. Buona lettura!
LINK ED APPROFONDIMENTI
- Maynard Solomon, Su Beethoven: musica, mito, psicoanalisi, utopia. Einaudi.
- https://www.udiscovermusic.com/classical-features/beethoven-choral-symphony-no-9/
- https://www.arkansassymphony.org/beethoven-ludwig-symphony-no-9-d-minor-op-125#close
- https://utahsymphony.org/explore/2015/11/beethoven-symphony-no-9-in-d-minor-op-125-choral/
- https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=5487727&t=1580154504825
- Giorgio Zanchetti in “I luoghi dell’arte”, Electa Mondadori 2003